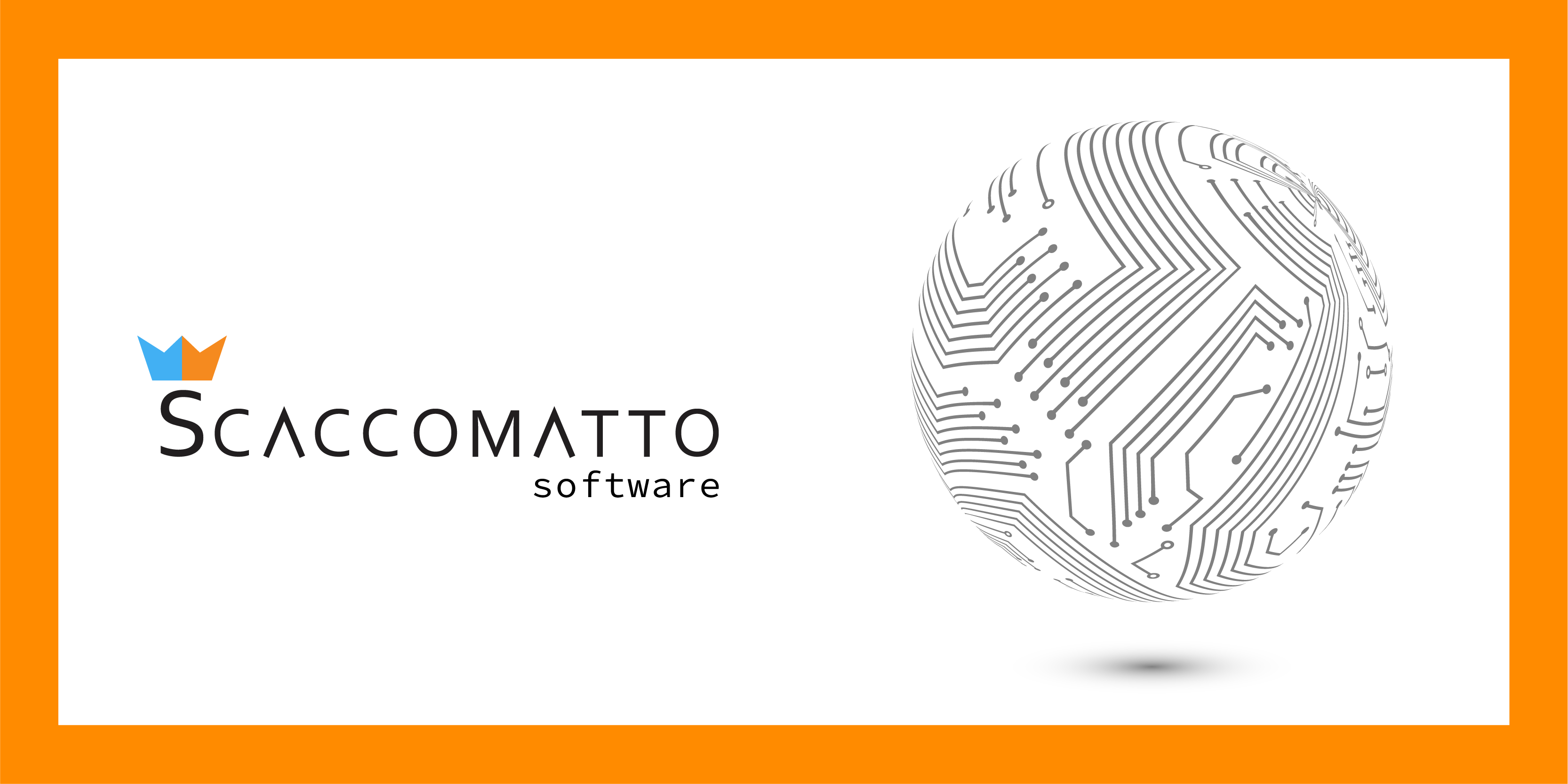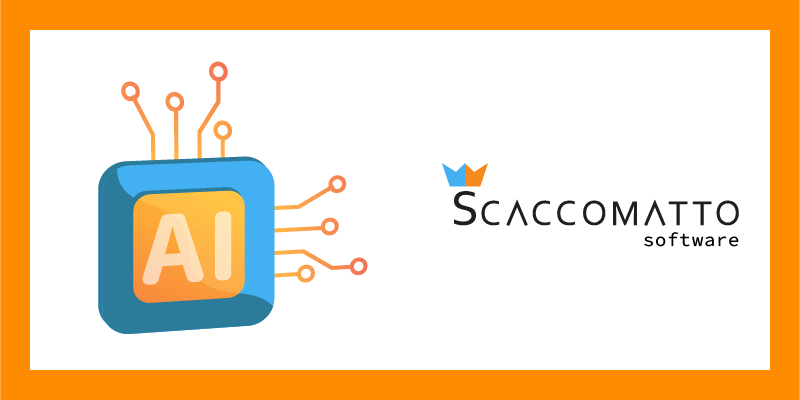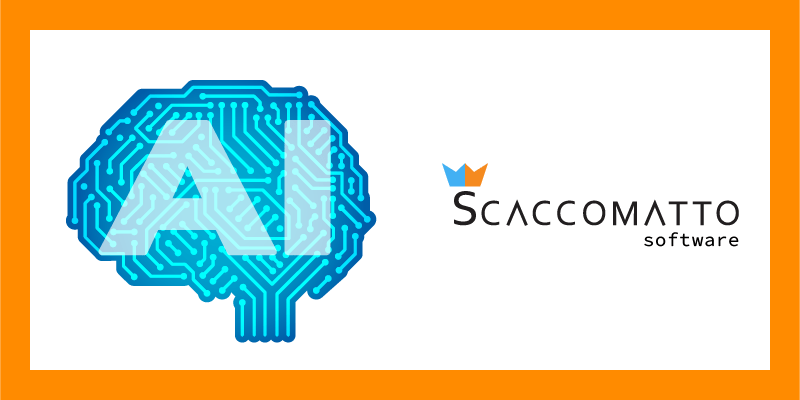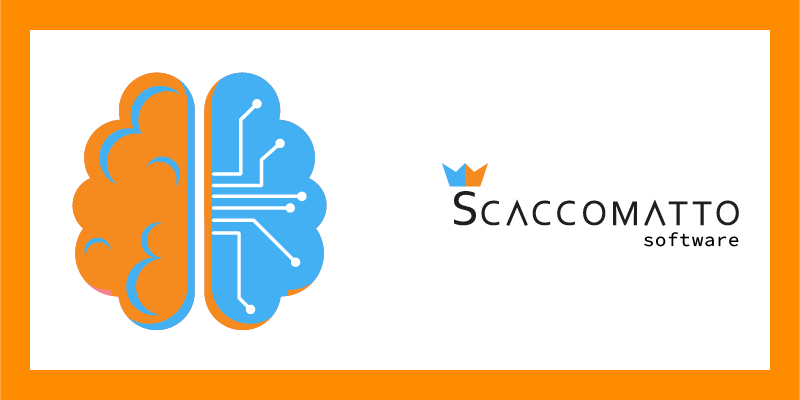Nel mondo dell’informatica, due decenni rappresentano un arco temporale considerevole, eppure Arduino in questi vent’anni non si è limitata a resistere al passare del tempo: ha ridefinito radicalmente l’approccio di milioni di persone all’elettronica e alla programmazione. La storia che stiamo per raccontare riguarda una piattaforma che ha reso la tecnologia accessibile a tutti, e tutto è iniziato in un piccolo bar della città piemontese di Ivrea.
Da dove viene quel nome
La denominazione “Arduino” racchiude in sé un pezzo significativo della narrativa che circonda questa iconica piattaforma elettronica open source italiana. Il riferimento è al “Bar di Re Ardoino”, punto di ritrovo abituale dei fondatori del progetto nella città di Ivrea. L’esercizio commerciale portava il nome di Arduino d’Ivrea, sovrano d’Italia nell’undicesimo secolo, una personalità storica che probabilmente non avrebbe mai immaginato di prestare il proprio nome a un’innovazione tecnologica così rilevante del ventunesimo secolo.comunicaffe+1
La genealogia del progetto affonda però le radici in un’esperienza precedente. Nel 2004 esisteva già Wiring, una piattaforma creata da Hernando Barragán, studente colombiano presso l’Interaction Design Institute Ivrea (IDII). La supervisione della tesi di Barragán era affidata a Massimo Banzi, destinato a diventare una delle figure chiave nella creazione di Arduino. Wiring rappresentava già un’innovazione significativa, ma il suo costo risultava proibitivo per gli studenti che avrebbero dovuto utilizzarlo.people.interactionivrea
La genesi dell’idea
La concezione di Arduino può essere attribuita a un gruppo di cinque individui: Massimo Banzi, David Cuartielles, David Mellis, Gianluca Martino e Tom Igoe. L’intento era sviluppare una soluzione ancora più economica e facilmente utilizzabile rispetto a Wiring, destinata specificamente ai corsi tenuti presso l’istituto di Ivrea. Prima dell’avvento di Arduino, realizzare dispositivi dotati di interattività richiedeva competenze elettroniche e ingegneristiche avanzate, creando una barriera d’ingresso insormontabile per chi non possedeva una formazione tecnica specialistica.irideprogetti+1
La scelta di Ivrea come luogo di nascita del progetto non è casuale: questa città piemontese aveva ospitato nel secolo precedente Olivetti. L’IDII era stato costituito grazie all’iniziativa di Telecom Italia e Olivetti, con l’obiettivo esplicito di perpetuare l’eredità innovativa del territorio. Il concetto alla base era tanto semplice quanto rivoluzionario: fornire a designer, artisti e studenti gli strumenti necessari per materializzare le proprie idee sotto forma di prototipi funzionanti, senza necessità di possedere una laurea in ingegneria elettronica.emcelettronica
Una decisione che ridefinisce tutto
L’elemento veramente dirompente di Arduino non risiedeva esclusivamente nell’aspetto tecnico, ma nella filosofia sottostante. Il team compì la scelta coraggiosa di rendere ogni componente completamente open source: gli schemi dell’hardware, il codice software, ogni singolo elemento del progetto. Si trattava di una mossa audace che oggi potrebbe apparire scontata, ma all’epoca rappresentava un approccio rivoluzionario al mercato. Chiunque avrebbe potuto accedere ai progetti, modificarli secondo le proprie esigenze, apportare miglioramenti e persino avviare la produzione di versioni alternative delle schede.ipsiaplcarduinolab.altervista
Massimo Banzi espresse questo concetto dichiarando: “La tecnologia non come strumento a esclusivo beneficio di chi vende”. Questa visione filosofica innescò una crescita dal ritmo sorprendente. La realizzazione del primo prototipo richiese solamente cinque giorni complessivi: David Mellis completò lo sviluppo del codice nell’arco di due giorni, mentre la materializzazione della scheda fisica avvenne nei tre giorni seguenti. Il primo lotto produttivo, costituito da circa duecento unità, venne avviato nel maggio del 2005.corriere+2
L’espansione su scala globale
Le settimane iniziali dopo il lancio rivelarono immediatamente le potenzialità del prodotto. La comunità di utilizzatori si espanse con rapidità impressionante, attratta dalla semplicità operativa e dall’accessibilità economica della piattaforma. Tuttavia, il successo portò con sé anche problematiche organizzative. Nel 2008 venne costituita Arduino LLC sul territorio statunitense, con il mandato di gestire il marchio e coordinare lo sviluppo software. La responsabilità della produzione fisica delle schede rimase in Italia, affidata a Smart Projects (successivamente denominata Arduino SRL) sotto la guida di Gianluca Martino.emcelettronica+1
Questa divisione operativa sembrava funzionare efficacemente, ma celava tensioni destinate a esplodere negli anni successivi. Nel frattempo, Arduino continuava la sua espansione attraverso nuove varianti: dalla scheda Mega, progettata per progetti di maggiore complessità, alla Nano, concepita per applicazioni che richiedevano dimensioni ridotte. La comunità raggiunse milioni di utenti distribuiti in ogni angolo del pianeta.emcelettronica+1
Quando Arduino combatte contro Arduino
Le frizioni interne si trasformarono in una drammatica scissione organizzativa. Tra il 2014 e il 2015 esplose un contenzioso legale tra Arduino LLC (con Banzi alla guida) e Arduino SRL (acquisita da una holding svizzera con Federico Musto nel ruolo di CEO). L’oggetto della disputa riguardava la titolarità del marchio “Arduino” nei mercati italiano ed europeo.vice+1
Per garantire la continuità operativa durante l’iter giudiziario, il team guidato da Banzi introdusse una nuova denominazione commerciale: Genuino. Le schede marchiate Genuino erano tecnicamente identiche alle Arduino, ma potevano essere commercializzate legalmente nei territori dove il marchio originale era oggetto di contestazione. Si trattava di un espediente temporaneo che generò confusione nella comunità e danneggiò la percezione pubblica del progetto.arduino+4
La risoluzione del conflitto arrivò nel 2016, quando le parti contendenti annunciarono la riunificazione sotto un’organizzazione unificata. L’anno seguente, nel 2017, Fabio Violante, ingegnere informatico con significativa esperienza manageriale, assunse la carica di CEO di Arduino SA, ricevendo l’incarico di guidare l’azienda verso una nuova fase evolutiva.deib.polimi+2
Il cambiamento introdotto da Arduino
Questo dispositivo ha ridefinito permanentemente l’approccio alla prototipazione nel campo dell’elettronica. La visione alla base del prodotto mirava a introdurre una prospettiva completamente nuova sulla tecnologia: non più dominio esclusivo degli ingegneri specializzati, ma strumento accessibile a chiunque nutrisse il desiderio di trasformare un’idea in realtà tangibile.
Arduino ha generato un ecosistema di portata planetaria. Attualmente la piattaforma può vantare oltre 33 milioni di utilizzatori, spaziando dagli studenti delle scuole secondarie ai ricercatori universitari, dagli artisti ai maker, dagli appassionati ai professionisti del settore industriale. La piattaforma è stata impiegata nella realizzazione di progetti estremamente variegati: sistemi robotici, droni, stazioni meteorologiche, installazioni artistiche, dispositivi per l’Internet of Things, prototipi destinati all’industria.spazio50+1
La produzione è rimasta ancorata al territorio italiano, specificamente nell’area compresa tra Ivrea e Strambino, preservando quel legame con il territorio che aveva dato origine al progetto. Nel corso degli anni, numerosi competitor hanno tentato di replicare il modello, ma Arduino ha mantenuto la posizione di standard di riferimento grazie alla facilità d’utilizzo e all’ampiezza della comunità di supporto.emcelettronica
Il futuro si manifesta ora
Nell’ottobre del 2025, a vent’anni di distanza da quel primo lotto produttivo di duecento schede, arriva il riconoscimento che sancisce definitivamente il valore del progetto: Qualcomm Technologies, gigante americano nel settore dei semiconduttori, ufficializza l’acquisizione di Arduino. L’operazione è finalizzata a creare una sinergia tra la piattaforma accessibile di Arduino e le tecnologie d’avanguardia di Qualcomm: intelligenza artificiale, machine learning, Internet of Things di ultima generazione.key4biz+2
Arduino manterrà la propria identità di marchio indipendente sotto la direzione di Fabio Violante, proseguendo quella missione di democratizzazione tecnologica che ne ha determinato il successo globale. Il prodotto inaugurale di questa nuova era è l’Arduino Uno Q, una scheda che incorpora processori Qualcomm e introduce capacità di intelligenza artificiale sulla piattaforma più rappresentativa del catalogo.spazio50
Dal bar di Ivrea a 33 milioni di utilizzatori distribuiti sul pianeta intero. Da cinque persone unite da un’idea visionaria a componente di uno dei colossi della tecnologia mondiale. Arduino ha dimostrato che l’Italia possiede le capacità per competere ai massimi livelli nell’innovazione tecnologica, che l’approccio open source non rappresenta semplicemente un modello sostenibile ma vincente, e che le rivoluzioni più significative nascono quando la tecnologia diventa patrimonio accessibile all’intera collettività.
Oggi, tutti i principali sistemi di prototipazione elettronica hanno incorporato filosofie analoghe, interfacce semplificate e comunità aperte alla collaborazione. Arduino non ha semplicemente creato un prodotto commerciale: ha dato vita a un movimento culturale che ha trasformato permanentemente il mondo dell’elettronica.